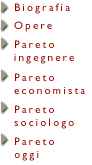|
|
Pareto
in breve
|
|
Pareto
sociologo
|
Traduzione
e sintesi di uno scritto di Giovanni Busino.
È possibile il download
della versione integrale originale inglese. 
|
|
|
| Il
metodo della sociologia paretiana
|
|
Nel
Trattato di sociologia generale (1916) Pareto porta
a compimento la sua organizzazione della sociologia, una
scienza sociale generale "di carattere esclusivamente sperimentale",
che ha il compito di studiare i legami mutuamente dipendenti
che correlano tra loro i fatti sociali e di rivelarne le
uniformità. L'analisi avviene per approssimazioni
successive, cosicché economia pura, economia applicata
e sociologia rappresentano tre successivi affinamenti dello
studio del comportamento umano. La scienza non è né una
ricostruzione/restituzione della realtà sociale, né una
sua mera immagine riflessa, né tantomeno una sua copia più
o meno impressionistica. Al contrario, mediante un'estrapolazione
dall'universo reale, la scienza costruisce oggetti scientifici
ed elabora teorie, definendo le relazioni che uniscono tra
di loro gli oggetti scientifici; utilizza quindi i risultati
ottenuti per l'edificazione di universi semplificati.
Fondamento di ciascuna analisi è l'azione - il comportamento
dell'individuo mirato a un determinato obiettivo - che Pareto
descrive in tutte le sue complesse trame di interdipendenza,
elaborando una teoria per cui l'azione stessa costituisce
l'oggetto-sistema. Tali costruzioni
teoriche sono "semplici ipotesi, che vivono sinché
stanno d'accordo coi fatti, e che muoiono e scompaiono quando
nuovi studi distruggono quest'accordo". (Trattato di
sociologia generale, § 52).
|
|
|

|
Azioni
logiche e non-logiche |
Pareto
distingue le azioni logiche che "sono, almeno per la parte principale,
il risultamento di un ragionamento" dalle azioni non-logiche, che
"hanno origine principalmente da un determinato stato psichico:
sentimenti, subcoscienza, ecc." (Trattato, § 161). Le azioni
logiche uniscono logicamente i mezzi al fine, relazione che deve
essere valida per colui che le compie, ma anche per tutti coloro
"che hanno cognizioni più estese" (id., § 150); tale carattere manca
invece alle azioni non-logiche. Le azioni logiche ricorrono a materiale
sperimentale e fatti oggettivi che sono correlati tra di loro da
ragionamenti rigorosi; le azioni
non-logiche, indubbiamente più numerose e di grande importanza
nella vita sociale, attingono alla logica in misura diversa.
A fianco a una logica dimostrativa, Pareto introduce una logica
non-dimostrativa, ovvero l'argomentazione plausibile e argomentativa.
Nell'ambito delle argomentazioni logiche e degli sviluppi di quelle
non-logiche, egli individua un fatto precostruito, stabile e latente,
che va al di là di qualsiasi spiegazione empirica - detto residuo
- e un nucleo manifesto e variabile, che può essere osservato empiricamente
- chiamato derivazione. La tipologia dell'azione logica corrisponde
a quella di un operatore, utile se il suo valore di previsione è
valido, se aiuta a formalizzare la relazione mezzo/fine; al contrario
inadeguato, se efficienza e costo non possono essere espressi secondo
un rapporto mezzo/fine, se i dati non sono quantificabili. Nel momento
in cui i fini non sono né dati né individuati, non è possibile ricondurli
alla razionalità formale del linguaggio scientifico, che è
diversa dalla razionalità strumentale dell'azione e della decisione.
Per evitare il paradosso eleatico, Pareto elabora la struttura ontogenetica
e filogenetica dei residui, sulla quale si basano il ragionamento
e l'equivoco, che determinano le scelte e le decisioni. In questo
modo, separa le rappresentazioni dall'azione, riconoscendo tuttavia
che possono avere una fonte comune, che risiede in un campo esterno
all'analisi sociologica, chiamato "stato psichico" (id., § 1690-2),
il cui studio è riservato agli psicologi.
|
|
| |
I
residui |
| Il
linguaggio rivela la tendenza dell'uomo a discutere e argomentare,
al fine di rendere plausibili e accettabili i propri comportamenti
e le proprie credenze; per mezzo di oggetti discorsivi, esso precede
qualsiasi altra forma di razionalità logico-sperimentale e strutturale.
I residui, entità inesistenti, sono al tempo stesso contenuto
e conscenza del senso comune, condizioni per l'elaborazione di strutture
con significanze simboliche. Frutto di una "logica" pre-costituita,
forniscono funzioni di identificazione, rappresentazione e nomenclatura;
costituiscono le implicite premesse di equivoco che vengono utilizzate
inconsapevolmente dagli attori sociali. I residui talvolta esprimono
emozioni, in altre occasioni sono dedotti da una rappresentazione;
mutano continuamente nel corso della storia, sia in numero che in
intensità. Poiché il concetto di residuo implica l'intenzione e
la sua simbolizzazione, "i sentimenti, il subcosciente, ecc.", trasfigurati
in relazioni simboliche, divengono oggetti intelligibili e comprensibili
e di conseguenza accessibili. Situati al di là del linguaggio scientifico,
i residui
trascendono l'esperienza e la logica, garantendo ampia autonomia
al linguaggio naturale. |
|

|
Le
derivazioni |
| Dal
canto loro, le derivazioni, risultato dell'esperienza diretta, grazie
alla mediazione di tecniche argomentative, forniscono le ragioni
in grado di spiegare l'agire degli uomini; legittimando obiettivi
e mezzi, riempiendo e sistematizzando i vuoti del nostro sapere,
danno una apparente forma di verità ai valori, alle credenze, alle
convinzioni degli attori sociali, e contribuiscono altresì a consolidare
i sentimenti. Fondate sul linguaggio, le derivazioni, grazie ai
trattati rendono i residui intelligibili, ma non sono adatte a trasformare
le asserzioni in proposizioni verificabili. Le
derivazioni
non hanno un valore intrinseco e non svolgono una funzione diretta
nell'elaborazione dell'equilibrio sociale: sono semplicemente manifestazioni
e indicazioni di altre forze, "quelle che intervengono effettivamente
nella determinazione dell'equilibrio sociale". |
|
| |
Residui,
derivazioni e utilità sociale |
| "Come
operano tali residui e tali derivazioni? In che relazione è quest'opera
coll'utilità sociale"? (Trattato, § 1687) Secondo una prospettiva
statica, Pareto analizza, innanzitutto, la distribuzione dei residui
in una data società, nonché in strati diversi della medesima; quindi,
secondo una prospettiva dinamica, esamina in che modo i residui
variano nel corso del tempo, in individui appartenenti a un medesimo
strato sociale, o in seguito al mescolarsi di diversi strati sociali,
senza trascurare lo studio di come tali fenomeni si manifestano.
I residui e le derivazioni si propagano per imitazione o a causa
di altre circostanze. Lo studio dei processi di propagazione mostra
altresì l'esistenza di un terzo fattore: gli interessi. Condizioni
d'intelligibilità dell'azione, privi di esistenza obiettiva,
legati fra loro da mutua dipendenza o causalità multipla,
i residui, le derivazioni e gli interessi, fattori necessari all'equilibrio,
non possono tuttavia essere completamente afferrati. Il metodo è
allora carente? No, in quanto, anche lo stesso "concetto, sia pure
imperfetto, dell'interdipendenza" rimuove le difficoltà di una spiegazione
fondata su una singola struttura causale. Tale metodo suggerisce
inoltre come i residui siano più costanti rispetto alle derivazioni
e come, in parte, ne siano la 'causa', senza dimenticare l'opera
secondaria delle derivazioni, che, talvolta, sia pure subordinatamente,
possono essere 'causa' dei residui". (id., § 1732). Grazie a tale
sistema di relazioni, variabili da società a società, da una classe
sociale all'altra, da un'era all'altra, è possibile una mediazione
tra strutture obiettive interiorizzate e condotta individuale.
|
|
 |
L'equilibrio
sociale |
Ogni
società è costituita da diversi elementi interdipendenti (suolo,
clima, fauna, flora, azioni esercitate da altre società, storia,
razza, residui, derivazioni, interessi) che concorrono alla costituzione
di un sistema sociale. "Tale sistema muta forma e carattere col
tempo e, quando nominiamo il sistema sociale, intendiamo questo
sistema considerato tanto in un momento determinato quanto nelle
trasformazioni successive che subisce in uno spazio di tempo determinato".
(Trattato, § 2066). Per procedere alla sua analisi è necessario
definire uno stato in un dato momento: questo rappresenta lo stato
d'equilibrio. È manifesto che vi siano interruzioni dell'equilibrio
(guerre, epidemie, alluvioni, terremoti e altre calamità); tuttavia
lo stesso concetto di squilibrio implica un ritorno automatico allo
stato di equilibrio. Pareto pone l'accento sulle relazioni di interdipendenza,
non considera né i fini ultimi, né gli obiettivi indeterminabili
esterni al sistema; non si occupa di fornire una vera e propria
teoria generale dell'equilibrio sociale, quanto piuttosto una teoria
di un sistema empiricamente determinato, teoria che non risulta
adatta a spiegare né il passaggio da un sistema all'altro,
né la stessa ragione dello squilibrio.
Composta da gruppi differenti, tra di loro antagonisti per età,
sesso, forza fisica, salute, ecc., la società non è un'entità
omogenea e l'equilibrio pertanto è precario. Conflitti di utilità
e di interessi, divisioni, differenze di valori implicano divergenze
di obiettivi che generano eterogeneità
e mettono in luce la mancanza di razionalità della società. Nell'impossibilità
di stabilire quali siano i mezzi più appropriati per conseguire
un fine, di individuare l'obiettivo per il quale viene intrapresa
l'azione, di rendere omogenei i criteri che determinano scelte,
deliberazioni e azioni mirate a raggiungere l'utilità, in breve
nell'impossibilità di individuare i fini, Pareto non fornisce alcuna
precisa indicazione su come conciliare la razionalità dell'azione
con la razionalità epistemica nell'interpretazione dell'agire storico-sociale. |
|
| |
L'andamento
ondulatorio degli eventi storici |
| Quando
i residui subiscono lente trasformazioni, anche le società mutano.
La tesi in base alla quale la ragione ha un ruolo preponderante
nell'agire umano "è indefinita come tutte quelle che
la letteratura sostituisce ai teoremi della scienza, e facilmente
dà luogo a parecchi errori". Il progresso si manifesta
seguendo un andamento ondulatorio o ritmico, con oscillazioni caratterizzate
da ampiezza, durata e intensità diverse; nel momento in cui un fenomeno
raggiunge la sua massima intensità, in generale è prossima l'oscillazione
nella direzione opposta. Questo impedisce di spiegare i fenomeni
sociali tramite una semplice causalità lineare, o mediante
un determinismo più o meno rigido. Le rivoluzioni politiche, sociali
e religiose sono eque, giuste e necessarie per alcuni, e ingiuste,
inique e inutili per altri. Tutto ciò non ha alcun valore da un
punto di vista scientifico. "Una proposizione scientifica è vera
o falsa, non può adempiere un'altra condizione, come quella di essere
liberale o socialista". "La scienza non si occupa che di constatare
i rapporti delle cose, dei fenomeni, e di scoprire le uniformità
che questi rapporti presentano. Lo studio di quelle che si chiamano
cause, se con ciò si intendono dei fatti in certi rapporti con altri,
appartiene alla scienza e rientra nella suddetta categoria delle
uniformità. Ma quelle che si dicono le cause prime, e in genere
tutte le entità che oltrepassano i limiti dell'esperienza, si trovano
per ciò stesso fuori del campo della scienza." (Les systèmes
socialistes, Indrod., I) |
|
 |
Le
élites e la loro circolazione |
| La
società è suddivisa in classi e gruppi eterogenei, ma all'interno
di classi e gruppi e tra classi e gruppi esiste un'intensa circolazione
orizzontale e verticale. Gruppi e classi sono in conflitto tra loro,
ma esistono altrettanti conflitti all'interno delle stesse classi
e degli stessi gruppi. La parte di un gruppo o di una classe che
cerca di conquistare l'egemonia sul proprio gruppo o sulla propria
classe, o su tutti i gruppi e tutte le classi, viene definita élite.
La teoria dell'élite vuole essere una generalizzazione della teoria
della lotta di classe. Lo strato superiore di una società
è costituito dagli individui che dimostrano spiccate capacità nei
vari campi dell'agire sociale, e comprende generalmente i governanti,
mentre lo strato inferiore è composto dai restanti individui, i
governati (vedi Trattato, § 2047). Una simile stratificazione
della società, consolidata altresì dalla teoria della distribuzione
delle ricchezze, è fondata
sulla natura umana, sul ruolo della fecondità e della mortalità
dei gruppi sociali e su una serie di altri fattori; non è il prodotto
di forze economiche o di capacità organizzative particolari. Per
quanto evidenzi varie ragioni che possono determinare la scomparsa
di una élite (distruzione biologica, cambiamenti psicologici negli
atteggiamenti, decadenza), Pareto individua le modalità per conservare
la stabilità e la continuità sociale: eliminare i contestatori che
mettono a repentaglio l'ordine sociale e l'esistenza della élite
e/o assorbire quegli elementi della classe governata che possono
risultare utili o utilizzabili. Tale processo di endosmosi, in base
al quale elementi della classe governata entrano a far parte dell'aristocrazia
al potere, corrisponde al "fenomeno
della circolazione sociale", e l'élite capace è quella in
continua fase di rinnovamento e ringiovanimento. Può accadere che,
per eliminare i propri avversari al potere, gli oppositori dell'élite
cavalchino l'onda del malcontento della classe governata o chiedano
interventi esterni. In tal caso, la classe al potere dovrà difendersi:
con astuzia e forza, ma anche con il consenso passivo della classe
governata. |
|
| |
Tipi
di sistema sociale |
Un
ordine sociale "aperto" è il risultato dell'equilibrio tra il residuo
dell'istinto delle combinazioni e quello della persistenza degli
aggregati; tra innovazione, scoperta e invenzione da una parte e
conformità a regole, morale e valori sociali e tradizionali
dall'altra. La distribuzione dei residui tra individui e classi
è alla base del tipo di sistema sociale: ove prevalga l'istinto
delle combinazioni vi sarà un grande numero di speculatori, imprenditori,
riformatori, inventori e individui ambiziosi capaci delle iniziative
più rischiose, mentre ove si registri una forte concentrazione del
residuo di persistenza degli aggregati vi sarà una prevalenza di
"rentiers", contrari ai cambiamenti e per i quali il passato
è un bene presente. Gli speculatori tendono a prevalere grazie all'inganno,
all'astuzia e ad altre forme di manipolazione; tuttavia, non sono
in grado di mantenere a lungo il controllo della situazione; vengono
allontanati dai "rentiers" che, a loro volta, verranno
spodestati dal potere degli speculatori, in una sorta di moto perpetuo,
dall'andamento ciclico.
Aumento della sicurezza individuale e collettiva, crescita del benessere
e convivenza pacifica indeboliscono lo spirito di iniziativa e rafforzano
la reticenza dei governi a fare uso della forza. Parallelamente
nuove idee e nuovi valori trovano ampia diffusione, facendo vacillare
i modelli culturali tradizionali: questo scuote l'autorità, e rende
possibile la ribellione. L'antico equilibrio sociale viene sostituito
da un nuovo equilibrio e una nuova classe prende il posto di quella
vecchia con la forza. I cambiamenti sociali sono semplici rotazioni
senza fine di minoranze che mirano soprattutto al controllo del
potere; corrispondono quindi a un cambiamento della forma, non della
sostanza e della struttura del potere. Solo una realtà è perenne:
la stratificazione della vita politica e sociale, tra governanti
e governati, in una struttura essenzialmente oligarchica. I politici
promettono cambiamenti radicali, ma non appena salgono al potere
assumono la difesa di una società che non ha nulla a che
vedere con le promesse fatte. Di conseguenza la vita sociale è un
inferno, una crudeltà senza fine e gli agenti sociali non sono altro
che vittime di illusioni e di miti. All'uomo non resta che uno spiraglio
di luce, una sola arma con cui combattere: la scienza. |
|